
SCHEDA INFORMATIVA A CURA DI ARCHEMAIL
Il territorio di Miseno
entrò a far parte della storia dei Campi Flegrei, poco dopo la fondazione di
Cuma da parte di coloni greci. Durante il VI sec. a.C., infatti, l'area
misenate costituì uno dei punti fondamentali del sistema difensivo attuato
dai Cumani per la difesa del Golfo di Napoli: tale fortificazione rimase in
uso almeno fino al III sec.a.C., quando Annibale si spinse fin qui per le
sue devastazioni.
Nuovo impulso all'urbanizzazione del territorio flegreo, si ebbe a partire
dalla fine del II sec. a.C. quando vennero impiantate numerose e lussuose
ville ed impianti ad esse connessi.
La cittadina sorta sull'attuale Marmorto fu denominata Misenum, toponimo
derivato dall'omonimo trombettiere di Enea, annegato in quelle acque.
Misenum inizialmente fu sede di ville marittime; a partire dall'inizio del I
sec. d.C. ritornò alla sua primitiva vocazione militare. Augusto, dopo la
battaglia di Anzio (31 a.C.), pose qui la base della Classis Praetoria, la
flotta al diretto servizio della corte imperiale, spesso presente nei Campi
Flegrei.
Il porto di Misenum, al pari del Portus Iulius sul lago Lucrino, venne
impiantato in due bacini naturali; il bacino interno, l'odierno Maremorto,
fungeva da cantiere navale, mentre quello esterno, la baia di Miseno,
costituiva il porto vero e proprio. Essi erano collegati da un canale oggi
interrato mentre l'ingresso al porto era protetto da due moli su arcate,
prolungamento dei baluardi naturali di Punta Terone e Punta Pennata. In
funzione della flotta venne anche dedotta una colonia militare che conferì
all'insediamento autonomia amministrativa. Lungo la costa furono installate
tutte le attrezzature necessarie ad una base militare che doveva ospitare
6000 uomini; caserme, alloggi per gli ufficiali, fari e torri, arsenali,
depositi e le monumentali opere di idraulica per il rifornimento dell'acqua
alla flotta.
Tranne che per un breve periodo di attività bellica (68-69 d.C.) nel golfo
ligure, la flotta Misenate restò inoperosa per secoli, con l'unico compito
di trasportare o scortare membri della famiglia imperiale.
Fino al IV sec. d.C. Misenum mantenne il suo ruolo cruciale dal punto di
vista militare poi il declino. Nel VI sec. d.C. della base militare di
Misenum si era perso anche il ricordo.
IL PORTO DI MISENUM
Il porto di Misenum, così come il precedente Portus Iulius (il complesso
Averno/Lucrino), era formato da due bacini naturali. Quello interno,
l'odierno Mare Morto, era utilizzato come bacino di allestimento e
riparazione delle navi, mentre quello esterno, la rada di Miseno, costituiva
il porto vero e proprio. I due bacini erano poi collegati da un canale, oggi
interrato. L'imboccatura del porto era protetta da due moli ad archi, uno da
Punta Terone, l'altro da Punta Pennata. Due tunnel, aperti sotto Punta della
Sterparella e sotto Punta Pennata, dovevano facilitare il gioco delle
correnti marine, per evitare l'insabbiamento del porto.
Nel porto trovava posto la flotta, costituita da una nave ammiraglia (un'esera)
e da diverse navi (liburnae, triremi, quadriremi, quinqueremi). A capo della
flotta era un membro dell'ordine equestre col grado di prefetto (praefectus
classis), uno dei gradi più ambiti per la carriera che essi schiudevano.
All'incompetenza marinaresca del prefetto, supplivano i comandanti di
squadra (navarchi).
Degli impianti portuali misenati non esiste quasi più nulla: in giornate di
buone condizioni del mare, si possono scorgere, a pochi metri di profondità
di fronte a Punta Terone, i resti di alcune pilae che sorreggevano i moli di
protezione del bacino. Da notizie raccolte sul posto, inoltre, sembra che,
poco distante dall'ingresso del porto, vi siano alcune colonne sommerse,
lasciando intuire la presenza di un tempio in quel luogo. Su Punta della
Sterparella sono, infine, alcuni ruderi che potrebbero appartenere alla
residenza del prefetto della flotta, da dove Plinio il Giovane osservò
l'eruzione vesuviana del 79 d.C.
LA COSIDDETTA "GROTTA DELLA DRAGONARA"
Scavata nella parete tufacea, a picco sulla spiaggia di Miseno (lato verso
Procida), è la Grotta della Dragonara, una grossa cisterna (m.50x59) a
cinque navate, pertinente alle infrastrutture funzionali alla flotta. Alcuni
la ritengono al servizio della vicina villa di Lucullo. La cisterna
attualmente si trova in uno stato di grosso abbandono, ridotta ad una
discarica.
LA VILLA DI LUCULLO
Adiacenti alla Grotta della Dragonara, scavati nel tufo, si aprono una serie
di ambienti pertinenti ad una villa: si distinguono pareti in cocciopesto e
strutture in opera vittata, reticolata e laterizia. Il primo ambiente,
partendo dalla spiaggia, è un ninfeo conosciuto anche col nome di "bagno del
finocchio". Queste strutture, forse ninfei e peschiere, dovettero
appartenere alla grandiosa villa prima di Mario e poi di Lucullo.
Successivamente la villa dovette passare al demanio imperiale.
LE TERME
In via Dragonara 54 si trovano i resti delle terme pubbliche di Misenum. Si
conserva il calidarium, il corridoio di servizio e l'impianto del
praefurnium. Tutto il complesso è databile al II sec.d.C.
LA CHIESA PARROCCHIALE DI SAN SOSSIO
Sul sagrato della chiesa sono conservati numerosi frammenti di decorazioni
architettoniche, capitelli corinzi di marmo, resti di colonne e di un
sarcofago strigilato di età tardo-imperiale.
IL SACELLO DEGLI AUGUSTALI
Su via del Faro si affaccia il monumento meglio conservato dell'antica
Misenum. Si tratta di un complesso destinato al culto dell'imperatore,
probabilmente il Templum Augusti quod est Augustalium, menzionato in una
delle epigrafi ritrovate nello scavo. Essendo la flotta uno strumento di
potere personale dell'imperatore, Misenum divenne una sorta di feudo della
famiglia imperiale dove più che altrove era sentito il culto della persona
dell'imperatore. Presumibilmente qui doveva collocarsi anche il piccolo foro
di Misenum, con gli edifici pubblici principali. Il tempio, risalente nelle
forme attuali al II°sec.d.C., è oggi in parte sprofondato per effetto del
bradisismo. L'ambiente centrale è il vero e proprio sacello, composto da una
cella rettangolare, con le pareti in reticolato e con un'abside nella parete
di fondo. Vi si accedeva tramite una gradinata marmorea fiancheggiata dalle
statue di Venere e dell'imperatore Nerva. Il pronao marmoreo tetrastilo era
formato da colonne in cipollino con capitelli a foglie d'acanto che
reggevano l'epistilio con l'iscrizione dedicatoria ed il forntone decorato.
Quest'ultimo, oggi al Castello di Baia, raffigura due Vittorie alate che
reggono una corona di quercia nella quale sono un uomo ed una donna; negli
angoli sono la prua di una nave ed un delfino. Difficile è l'identificazione
delle due figure poste al centro: la presenza del pileus (un berretto
sacerdotale), scolpito a rilievo tra i due ritratti, ha portato
all'identificazione con L.Laecanius Primitivus e la moglie, citati in una
delle iscrizioni dedicatorie esposte all'esterno. Infatti, sebbene sul
frontone del Sacello sarebbe stato lecito attendersi un ritratto imperiale,
in realtà siamo di fronte ad una composizione strettamente legata al
collegio degli Augustali di cui L.Laecinius Primitivus era un membro
prestigioso. Inoltre anche se la figura maschile presenta qualche
somiglianza con l'imperatore Antonino Pio, il volto femminile non ha alcun
punto di contatto con l'iconografia di Faustina, moglie di Antonino Pio.
La cella della struttura aveva le pareti rivestite di marmi ed il pavimento
in opus sectile (frammenti marmorei posti secondo uno schema geometrico) e
cocciopesto con riquadri di tessere bianche. L'abside era decorata con
stucchi a rilievo e, in alto, dipinta in rosso. Gli ambienti laterali erano
a due piani, con volte a botte. Dal Sacello provengono una decina di basi
dedicatorie, oggi conservate al Museo di Baia, tra le quali spicca quella
dedicata a L.Laecanius Primitivus, curator perpetuus degli Augustali di
Miseno, uno dei personaggi più influenti e munifici della città in età
antonina, come già precedentemente detto. Dall'ambiente di sinistra proviene
una statua equestre (oggi al Museo di Baia) originariamente creata per
Domiziano (81-96 d.C.) e riutilizzata, dopo la morte di quest'imperatore,
per raffigurare il suo successore Nerva (96-98 d.C.). L'imperatore, in sella
ad un cavallo impennato, di cu trattiene l'impeto tenendo con la sinistra le
redini, è raffigurato nel momento in cui scaglia una lancia. Si tratta di un
modello scultoreo che riflette un'ideologia militare e di conquista,
riservato ovviamente ai condottieri vittoriosi ad ispirazione di Alessandro
Magno. Sia la corazza che la tunica presentano motivi decorativi a rilevo
strettamente connessi ai temi dell'ideologia domizianea. Poichè Domiziano
non era ben voluto dai gruppi più conservatori del Senato per il suo
atteggiamento dittatoriale, alla sua morte, il Senato ne decretò la damnatio
memoriae, un provvedimento che implicava la cancellazione di ogni segno
connesso alla memoria del personaggio in questione. Tuttavia la maggior
parte delle statue veniva riutilizzata, sostituendo le teste con quelle di
altri imperatori. Così avvenne per questa statua, alla quale si sotituì solo
la maschera facciale con quella di Nerva, lasciando intatta la parte
posteriore della testa.
IL
TEATRO
Alle spalle del Sacello degli Augustali si trovano i resti del Teatro,
inglobati in una villetta: ne restano solo qualche galleria, un pilastro e
parte del corridoio inferiore. Interessante caratteristica, deducibile dalla
pianta di T.Rajola (1768), era la presenza di un tunnel che dalla
tredicesima arcata del teatro portava direttamente alla via Herculea e
perciò al porto: attualmente tale galleria termina in mare.
IMMAGINI DEL SITO

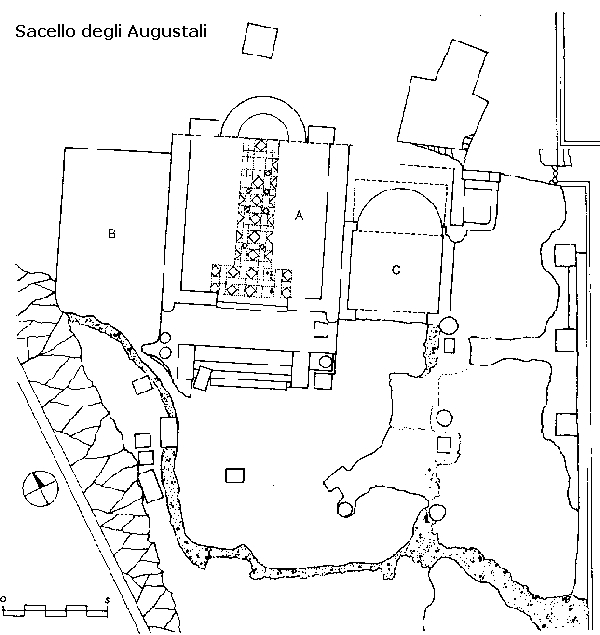
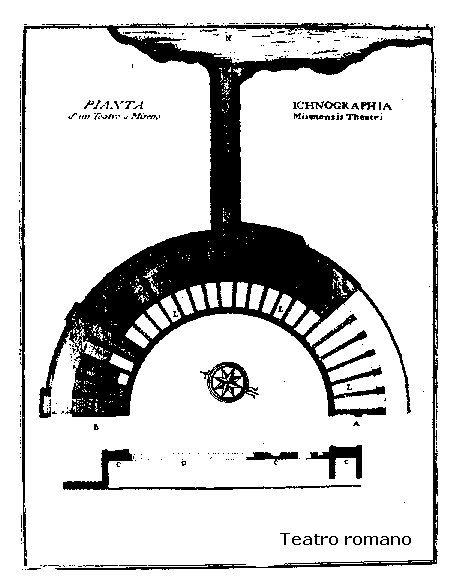
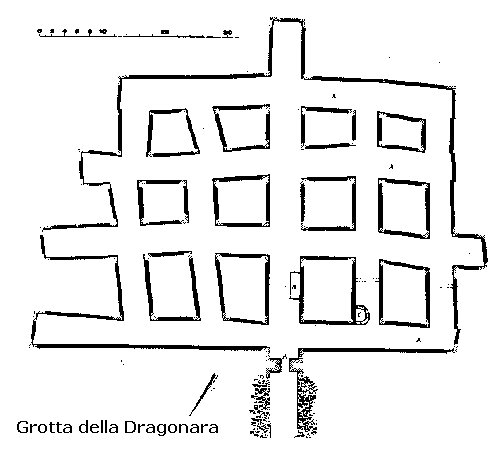
Non si assume alcuna responsabilità per eventuali difformità da quanto riportato in questa pagina