
SCHEDA INFORMATIVA A CURA DI ARCHEMAIL
Pozzuoli sorge quasi al
centro del territorio denominato Campi Flegrei: si tratta di un'area
essenzialmente vulcanica, formatasi a partire da 45000 anni fa. Il carattere
vulcanico è ancora oggi testimoniato da numerosi fenomeni quali la Solfatara
o le acque termali o il bradisismo. Quest'ultimo fenomeno consiste in lenti
movimenti verticali del suolo in zone circoscritte della superficie
terrestre, impercettibile all'uomo, ma rilevabile in zone costiere
osservando il livello del mare rispetto alla terra. L'area urbana di
Pozzuoli può essere suddivisa in tre zone, rispetto alla propria origine: il
Rione Terra, rupe di tufo giallo napoletano, residuo di un antico cratere;
la terrazza della Starza, antica linea di costa sollevatasi circa 10000 anni
fa; l'area della Solfatara, costituita da prodotti eruttati dal vulcano, ora
appunto in fase di "solfatara".
Sono troppo esigue le tracce a disposizione degli archeologi per stabilire
cosa vi fosse nell'area urbana di Pozzuoli in epoca preistorica e
protostorica. La storia documentata inizia soltanto nel 531 a.C. quando
alcuni profughi della città di Samo, in contrasto col governo locale del
tiranno Policrate, decisero di stanziarsi nell'area dell'attuale Rione
Terra: al nuovo sito venne dato il nome di Dicearchia, ossia "Città del
giusto governo". A quell'epoca, tutta la costa flegrea rientrava nella sfera
di Cuma e sicuramente, per fondare la loro città, i Samii dovettero chiedere
il permesso dei Cumani e dipendere politicamente da questi. Anzi è probabile
che sul luogo prescelto esistesse già una piccola colonia cumana con compiti
difensivi. Per dovere di cronaca, occorre anche dire che finora nessuna
traccia dell'abitato greco è stata trovata durante i saggi di scavo sul
Rione Terra.
Solo in età romana, la città cominciò ad acquistare una certa importanza per
la presenza del porto: a partire dall'epoca della deduzione di una colonia,
avvenuta nel 194 a.C., la città assunse il nome di Puteoli (forse da puteus,
nel significato di "pozzo" spiegabile con i numerosi crateri dell'area
flegrea, o da putidus, ossia "maleodorante", riferito alle esalazioni
solfuree). La bellezza del suo paesaggio ed il gran numero di sorgenti
termo-minerali del suo territorio, attirarono, nel corso del I°sec.a.C.,
l'interesse dei ricchi Romani che vi costruirono una serie di lussuose
dimore. Il poeta latino Lucilio già nel II°sec.a.C. la definì Delo Minore,
paragonandola alla località dell'Egeo che all'epoca era molto florida
riguardo all'attività economica. Fu anche per questo che Augusto eresse la
città al rango ufficiale di porto di Roma, con l'istituzione di una flotta
annonaria che provvedeva al vettovagliamento della capitale, trasportando
carichi di grano dall'Egitto e dalla Sicilia. Da allora la città fu in
continua crescita economica, ebbe un nuovo statuto di colonia e fu divisa in
regiones e vici (quartieri e borgate suburbane a carattere commerciale) che
ricalcavano quelli di Roma. Dopo Augusto, anche gli altri imperatori si
interessarono alla città. Nel 95 d.C. fu costruita la via Domiziana per
congiungere Pozzuoli direttamente a Roma, immettendosi sull'Appia,
all'altezza di Sinuessa (Mondragone). L'ampliamento del porto di Ostia,
voluto dall'imperatore Traiano, fu fatale per l'economia della città: iniziò
pertanto una lenta decadenza della città, che però solo nel V°sec., anche a
seguito di gravi fenomeni del bradisismo, si trasforma in vero e proprio
declino.
Fino al 1296, Pozzuoli restò un castro, ossia un centro abitato cinto da
mura, situato sul Rione Terra.
Rimasto sempre in vista durante il
medioevo, l'Anfiteatro Maggiore fu usato a lungo come cava di pietre da
costruzione e sistematicamente spoliato, subendo sorte analoga a quella del
Colosseo. Come il grande anfiteatro romano, anche quello flegreo fece da
sfondo alle persecuzioni anticristiane: in particolare fu testimone del
martirio del vescovo Gennaro e del puteolano Procolo, poi divenuti
rispettivamente patroni delle città di Napoli e Pozzuoli. Col tempo
sull'edificio vennero erette case e masserie e, nel 1689, anche una piccola
chiesa dedicata a S. Gennaro; la chiesetta fu sconsacrata e distrutta nel
1837, quando sotto Ferdinando II di Borbone fu disposto lo sterro del
monumento, che durò circa un secolo. Fra il 1839 e il 1845 l'architetto
Bonucci liberò gran parte dei sotterranei; in successive campagne, E.
Ruggiero (1850-1855) e G. Fiorelli (1880-1882) riportarono alla luce l'arena
e parte dei passaggi radiali. L'opera fu completata tra il 1926 e il 1947 da
A. Maiuri, cui si deve anche il primo studio scientifico dell'edificio.
Comunemente il monumento viene collocato in età flavia per la presenza di
un'iscrizione apposta in quattro copie su ciascuno degli ingressi
principali: COLONIA FLAVIA AUGUSTA PUTEOLANA PECUNIA SUA. Nella sua
incisività, l'iscrizione appare chiarissima: la città, onorata
dall'imperatore del titolo di Colonia Flavia Augusta [ha costruito] a
proprie spese. L'oggetto dovrebbe essere, secondo l'interpretazione più
ovvia, l'anfiteatro stesso.
Tuttavia, in base a recenti ritrovamenti epigrafici, si può proporre una
datazione neroniana dell'edificio, che per di più risulta estremamente
coerente con l'impianto urbanistico neroniano della città; inoltre, anche
l'uso dell'opera reticolata in alcuni punti dell'edificio potrebbe
confermare una datazione anteriore all'epoca flavia. Dunque deve essere
questo l'anfiteatro puteolano in cui, nel 66 d.C., si celebrarono i
grandiosi giochi in onore di Tiridate, re dell'Armenia, ricordati da Dione
Cassio. All'età flavia potrebbe essere ascritto, invece, il completamento
della costruzione e della decorazione, cui farebbe riferimento l'iscrizione
apposta sugli ingressi (va ricordato che la menzione del nome di Nerone era
proibita per la sua damnatio memoriae). Altri restauri vennero eseguiti nel
II secolo d.C.: furono modificati i sotterranei, costruiti interamente in
opera laterizia, e il porticato esterno.
L'edificio, terzo in Italia per dimensioni (m. 149x116) dopo il Colosseo e
l'anfiteatro di Capua, poteva contenere circa 20.000 spettatori. La
costruzione si elevava su tre ordini: i primi due, ad arcate, sostenevano la
cavea suddivisa in tre settori, summa, media e ima; l'ultimo si presentava
all'esterno 89 come un alto loggiato, con un muro continuo finestrato e
coronato da statue.
L'intero perimetro era percorribile a piano terra mediante tre ambulacri
concentrici, collegati tra loro da ambienti disposti radialmente. Il
percorso più esterno si sviluppava sotto le arcate di un portico su
pilastri, decorati all'esterno da semicolonne addossate. Dei due ambulacri
interni, uno era riservato al pubblico e correva nella zona mediana
dell'edificio, l'altro era destinato al personale di servizio ed era posto
dietro il podio lungo il perimetro dell'arena. In corrispondenza del secondo
ordine di arcate, al primo piano, era una galleria, anch'essa percorribile
lungo tutto il perimetro dell'edificio. Quattro ingressi principali a tre
fornici erano situati alle estremità degli assi maggiore e minore.
Un'articolata rete di corridoi assicurava, inoltre, numerosi percorsi
interni per gli spettatori e consentiva nello stesso tempo gli spostamenti
del personale di servizio, talvolta con l'espediente di utilizzare con
doppia funzione lo stesso passaggio.
I sotterranei (perfettamente conservati) si sviluppano secondo due assi
perpendicolari, individuati dai due corridoi principali e collegati tra loro
da un unico ambulacro anulare. All'esterno dell'anfiteatro era una platea
pavimentata a lastre di pietra e cinta da una cancellata.
Sostando in prossimità dell'ingresso moderno si può osservare l'entrata
principale ovest con ingresso a tre fornici. In quello centrale, così come
all'entrata sul lato opposto, una rampa in discesa immette nel corridoio
longitudinale dei sotterranei. Il percorso carrabile veniva utilizzato per
il trasporto delle attrezzature necessarie allo svolgimento degli
spettacoli. Ma prima dell'inizio delle rappresentazioni l'apertura di queste
rampe veniva chiusa con un tavolato affinché gli ingressi potessero essere
utilizzati dal pubblico. Superato il cancello moderno, dopo la biglietteria,
si percorre un vialetto che costeggia l'anello esterno dell'anfiteatro, dove
è attualmente collocato il lapidario flegreo.
Sulla sinistra è il porticato con i pilastri e le semicolonne costruiti in
blocchi di piperno; i pilastri sono posti in corrispondenza delle testate
dei muri radiali anch'esse rivestite da blocchi di piperno. Nel II secolo
d.C., per evidenti motivi statici, l'anello esterno venne rinforzato con
l'aggiunta di altri pilastri in opera laterizia, restringendo così
notevolmente lo spazio interno del portico, che in questa occasione venne
interamente ridipinto. Dall'anello esterno e dall'ambulacro interno nella
zona mediana si diramava la rete di percorsi per l'accesso alla cavea. Le
gradinate erano suddivise in tre settori da tre precinzioni interne e in
cunei numerati: nel lapidario sono ancora conservati numerosi frammenti
epigrafici con l'indicazione CVN (abbreviazione di cuneus) seguita da un
numero. Come avviene attualmente, i posti erano di maggiore o minore pregio
in rapporto alla distanza dall'arena: quelli più vicini erano riservati ai
senatori e ai cavalieri romani, oltre che ai magistrati e sacerdoti
cittadini.
La parte più alta, summa cavea, si poteva raggiungere dal piano stradale
esterno mediante rampe di scale. In totale erano previsti ventotto accessi
di questo tipo, collocati in ciascuno dei quattro settori dell'anfiteatro in
modo speculare. I passaggi erano così suddivisi: otto portavano dal portico
esterno direttamente alle uscite sulla cavea nel livello più alto, i
vomitoria (visibile nella quinta arcata dall'ingresso occidentale); dodici
doppie rampe, sempre partendo dal portico esterno, salivano fino alla
galleria del primo piano e di qui ai vomitoria (visibile nella decima e
nell'undicesima arcata dall'ingresso occidentale); otto rampe partivano,
invece, dall'ambulacro interno e salivano fino alla galleria al primo piano,
da dove poi con le altre scale si poteva salire al livello superiore.
Gli accessi ai settori più bassi della cavea erano distribuiti solo lungo
l'ambulacro interno. La media cavea era servita da quattordici scale,
situate ai lati dei fornici degli ingressi principali e simmetricamente in
ciascuno dei quattro settori. L'ima cavea si poteva raggiungere percorrendo
dodici corridoi in discesa oppure quattro scale situate ai lati dei fornici
sull'asse longitudinale. Dall'ambulacro di servizio più interno ancora, due
scale, poste in corrispondenza dei fornici sull'asse trasversale,
consentivano il passaggio verso quest'ultimo settore della cavea.
Alcuni ambienti radiali aperti sul portico esterno furono adibiti a scholae,
vale a dire sedi di associazioni e collegia professionali. In taluni casi
venne utilizzato anche lo spazio tra le arcate così da interrompere la
continuità del percorso esterno. Di queste sale oggi restano poche tracce.
Continuando a percorrere il viale lungo l'anello esterno, si giunge
all'ingresso intermedio sud. Esso presenta tre passaggi paralleli con arcate
su pilastri (si conservano le basi dei pilastri, lo zoccolo in marmo e
l'elevato dei muri perimetrali in opera laterizia).
Procedendo in direzione est (nella prima arcata dopo l'ingresso) sono i
resti del sacello decorato da Gaio Stonicio Trophimiano, identificato per il
ritrovamento in sito dell'iscrizione pavimentale di dedica. Il sacello era
rivestito di marmi, ora perduti, e decorato da numerose piccole statue
(rinvenute durante gli scavi). Ancora oltre (nella decima arcata
dall'ingresso meridionale) era una sede degli Scabillarii, una corporazione
di musicanti connessa alle attività teatrali, il cui collegio è stato
ritrovato nell'attuale via Marconi. All'esterno, tra i pilastri laterizi,
sono i resti del pavimento a mosaico nel quale era l'iscrizione che, anche
in questo caso, ha permesso l'identificazione.
In prossimità dell'ingresso est si può osservare la sistemazione della
platea esterna con la recinzione, separata con un gradino dalla strada
basolata di disimpegno dell'anfiteatro. In questo punto si conservano alcuni
dei pilastrini di sostegno con scanalature laterali dove venivano fissate le
griglie della cancellata.
Raggiunto l'ingresso principale est, si può entrare nell'arena (il passaggio
è nel primo fornice a sud). Ci si trova in questo punto sull'asse
longitudinale dell'anfiteatro e da qui si può avere una visione d'insieme
dell'arena e della cavea.
L'arena è attraversata al centro dalla fossa scenica, un'apertura verticale
che raggiunge il livello dei sotterranei sottostanti, dove in corrispondenza
era la media via, uno dei due passaggi principali. Queste strutture
permettevano di sollevare dal basso gli scenari dipinti che dovevano animare
i giochi nell'arena. L'apertura superiore poteva anche essere chiusa con un
tavolato, quando fosse necessario ricostituire un piano uniforme. Nello
stesso modo venivano sollevate dal basso le gabbie con le fiere o altre
attrezzature sceniche necessarie all'ambientazione dei combattimenti. I
passaggi dai sotterranei erano predisposti con botole quadrangolari di
piperno, collocate sul piano pavimentale dell'arena. Sui bordi delle botole
si possono vedere gli alloggiamenti delle cerniere per il tavolato di
chiusura e, all'esterno, una serie di piccole aperture quadrate (oggi chiuse
con blocchetti di tufo). In queste aperture erano infissi pali, lunghi tanto
da raggiungere il livello dei sotterranei. Sull'arena i pali formavano una
sorta di recinto di protezione per gli spettatori e soprattutto per il
personale di scena, nei sotterranei fungevano, invece, da sostegni per le
gabbie.
La prima precinzione dal basso racchiudeva otto file di gradini, la seconda
sedici e la terza quindici. La cavea era sovrastata da un portico colonnato
adorno di statue, del quale non si conserva in posto alcun elemento. Si
possono osservare i tre ordini di vomitoria, in relazione con i percorsi
descritti in precedenza, e una fila di finestre che illuminava l'ambulacro
interno, collocate tra la media e la summa cavea. Ai lati di questo ingresso
principale, come anche di quello simmetrico a ovest, si trovano le rampe di
accesso al sotterranei.
L'interesse dell'anfiteatro puteolano è in buona parte dovuto al perfetto
stato di conservazione del livello sotterraneo. La disposizione delle
strutture consente, infatti, di comprendere il funzionamento delle macchine
sceniche che venivano utilizzate per l'allestimento degli spettacoli:
scenari e gabbie, come si è detto, nonché gli argani che servivano per
sollevare tutto ciò fino al livello dell'arena.
La disposizione interna è semplice, ma estremamente funzionale. Lo spazio
utilizzato corrisponde grosso modo a quello dell'arena soprastante e risulta
suddiviso in quattro porzioni dai due corridoi principali. In corrispondenza
del muro perimetrale dell'arena è un corridoio ellittico, sul quale si
affacciano numerosi piccoli ambienti dove erano sistemate le gabbie per le
fiere. Sulla verticale del corridoio sono le botole disposte lungo il
perimetro dell'arena. Al momento dello spettacolo gli animali feroci
venivano fatti uscire dalle loro celle e entrare in gabbie che poi erano
sollevate verso l'alto fino all'arena.
Nei sotterranei è visibile anche parte degli impianti idrici
dell'anfiteatro. L'edificio era, infatti, dotato di un complesso sistema di
canalizzazione che convogliava le acque in una fogna centrale collocata
sotto il piano dell'arena. Fontane alimentate da cisterne erano disposte
negli ambienti radiali lungo il perimetro esterno, per soddisfare alle
necessità del pubblico e garantire la manutenzione.
IMMAGINI DEL SITO
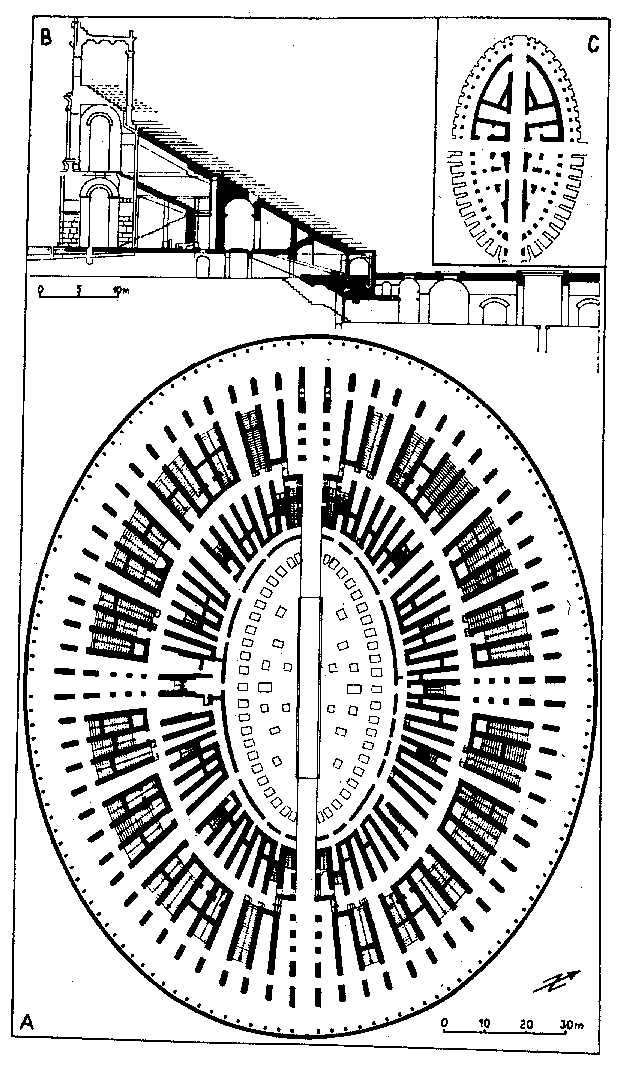





Non si assume alcuna responsabilità per eventuali difformità da quanto riportato in questa pagina