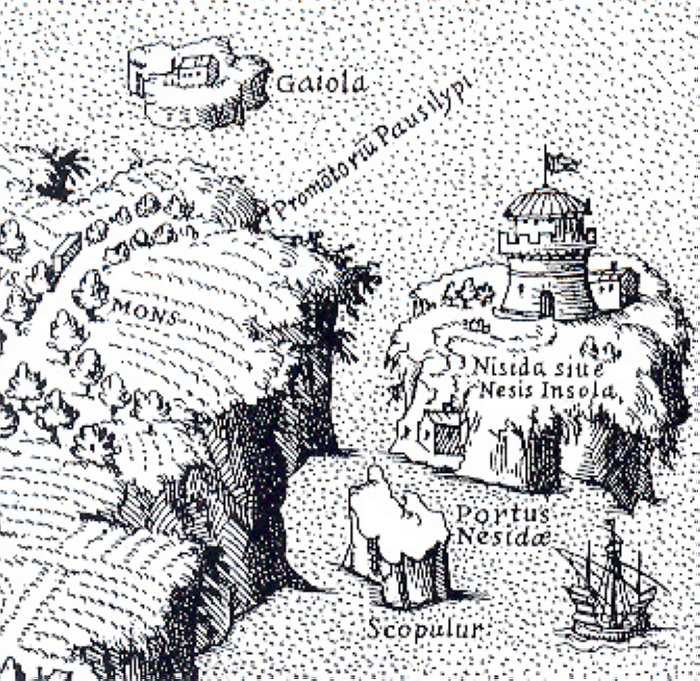|
La piccola isola di Nisida chiude
ad est l'arco del golfo di Pozzuoli. Essa risulta di difficile accesso a
causa della presenza del riformatorio giudiziario e di alcune strutture
della NATO. Questa sua inaccessibilità ha permesso di preservare quasi
intatte le sue risorse naturali, soprattutto nel versante
che dà verso il mare, occupato da un'insenatura chiamata
"Porto Paone".
Di origine vulcanica, come si intuisce dalla sua forma, emerge dal mare
per un sesto circa della sua mole originaria (superficie circa 30
ettari, circonferenza 2 km. ed altezza massima sul livello del mare 109
m.): infatti il cratere si formò attraverso esplosioni sottomarine che
poi hanno completato la loro opera al di fuori delle acque. Il tutto
ebbe luogo in epoca quaternaria, durante il III° periodo di formazione
dei Campi Flegrei, tra i 10500 e gli 8500 anni fa. L'ossatura del
vulcano è in tufo trachitico giallo compatto, contenente pomici e ceneri
leggere, segno che le ultime eruzioni avvennero alla luce del giorno.
Sull'orlo del cratere è presente uno strato di tufo grigio incoerente e
di pozzolane, prodotti più recenti attribuibili alle eruzioni del vicino
vulcano degli Astroni (3700 anni fa). Il cratere (caldera), che ha
un'apertura di circa 500 metri all'orlo, è oggi invaso dalle acque
marine: esso prende il nome di Porto Paone o Pavone per la sua forma
somigliante alla coda di questo uccello. La rovina del lato meridionale
della cinta craterica, che ha portato le acque del mare ad invadere il
cratere, venne causata dall'erosione marina ed atmosferica,
probabilmente collegata all'azione del vento di Libeccio. Altri
propendono per l'ipotesi che l'apertura verso il mare sia una
conseguenza dell'inclinazione craterica. Esaminando i fondali intorno
all'isola si è appurato che la base del vulcano ha un diametro di circa
1500 metri.
La vicina isoletta del Lazzaretto, oggi parte integrante del ponte che
unisce Nisida alla terraferma, ha invece un'origine diversa: detta
Leimon nell'antichità, essa era un frammento della cinta craterica del
vulcano di Posillipo, successivamente distaccatosi e caduto in mare.
Come gran parte dei Campi Flegrei, anche Nisida risentì e risente
tuttora del fenomeno del bradisismo: ne è testimonianza una vasta fascia
erosa dal mare, posta oggi a 5 metri di altezza sull'attuale livello del
mare e rappresentante il massimo livello di sprofondamento raggiunto
nell'XI° secolo, prima che il bradisismo invertisse la sua tendenza.
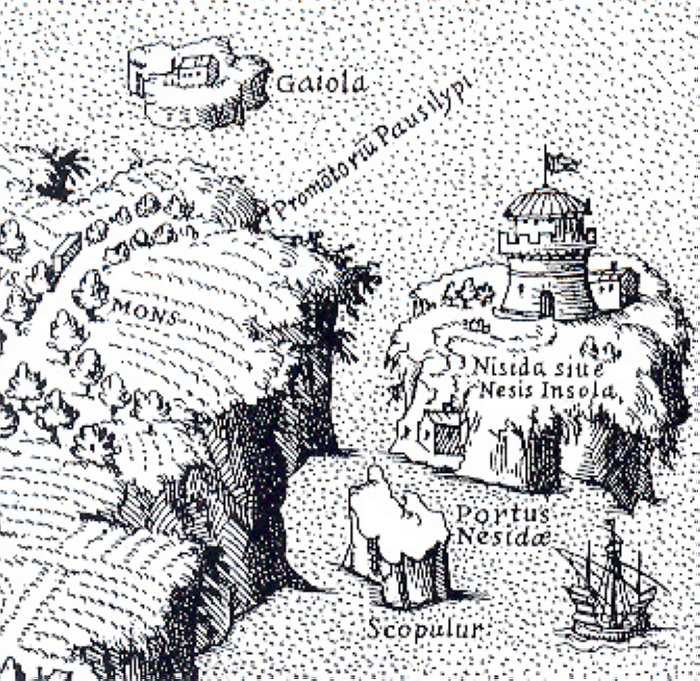 |
|
L'isola di Nisida
in una veduta di Francisco Villamena (1652) |
Nisida ha una antica storia da raccontare. Il suo
nome deriva dal termine greco "nesis"
che significa "piccola isola".
L'origine greca del nome fa pensare che l'isola, col suo approdo
protetto, non dovette passare inosservata ai primi colonizzatori greci
del Golfo di Napoli. Tuttavia manca ogni testimonianza di un eventuale
stanziamento abitativo greco (bisogna anche dire che non è mai stata
fatta un'indagine accurata alla ricerca di tracce antiche). Se si tiene
conto di alcune fonti antiche che parlano di una notevole attività
vulcanica ancora in età repubblicana (Stazio in Silv. libro 2, I, v.79:
"...inde malignum aera respirat pelago circumflua Nesis" e Lucano in
Phars. libro 6, v.90: "... tali spiramine Nesis emittit Stigiium
nebulosis aera saxis antraque letiferi rabiem Typhonis anhelant..."),
sembrerebbe impossibile ipotizzare una forma di stanziamento qualunque
in età greca.
Da più fonti apprendiamo dell'esistenza in età romana
imperiale di una villa appartenente a Lucio
Licinio Lucullo, famosa per gli imponenti banchetti che vi si
celebravano. Successivamente ebbe una dimora qui anche Marco Giuno Bruto, forse
un piccolo casino di caccia, senza molti di quei lussi che
caratterizzavano le ville della costa flegrea. In essa prese corpo la
congiura che porterà all'assassinio di Cesare (44 a.C.). Qui poi si
rifugiò per un breve periodo lo stesso Bruto dopo aver preso parte alla
congiura. La sua morte, avvenuta successivamente a Filippi, provocò un
tale dolore nella moglie Porzia, figlia di Catone
Uticense, rimasta a Nisida, da decidere di
togliersi la vita con l'unico mezzo che aveva a disposizione: ingoiando
carboni ardenti. Di queste dimore non si è finora
trovata traccia, anche se si suppone che sorgessero sul punto più alto dell'isola, per cui
eventuali tracce sarebbero state successivamente inglobate nell'attuale
penitenziario (qualche resto di muro di opera reticolata è sotto il
livello del mare dal lato ovest dell'isola). Comunque nell'ottobre 1956
fu rinvenuta sulla cima dell'isola una tomba a fossa, coperta di tegole
contenente resti umani e alcune brocchette di terracotta ascrivibili al
I° sec. d.C., mentre pare che agli inizi del XVII° secolo risalga il
ritrovamento di una tomba antica contenente un corpo imbalsamato con al
collo una collana con medaglia d'oro recante la scritta "M.A.ACILIUS,
C.F.III.R.".
Nell'alto medioevo l'isola venne ceduta in enfiteusi alla Chiesa
napoletana. Col tempo si perse anche la memoria dell'originario nome
tanto che, in alcuni documenti del XII° secolo, è citato un monastero di
S.Arcangelo o S.Angelo esistente sull'isola chiamata GIPEUM o ZIPPIUM,
riferendosi a Nisida. Parecchi dubbi sorgono sulla dislocazione di tale
monastero del quale non esistono oggi tracce evidenti. Presumibilmente
si trovava anch'esso dove oggi sorge il penitenziario, sul punto più
alto dell'isola: in particolare l'attuale edificio detto "Cortile delle
scuole", presenta segni di rifacimento su strutture preesistenti che
danno l'idea di un piccolo chiostro: si tratta di ipotesi che per ora
non è possibile controllare.
 |
|
Pianta di Nisida
di Vincenzo de Ritis: si notino i sette piloni dell'antico molo
romano al di sopra del molo
verso l'isola del Lazzaretto |
Durante l'età angioina l'isola appare citata in un inventario di beni
della Chiesa napoletana datato 1485: in esso si allude fra l'altro
all'esistenza di una torre. Nel XVI° secolo l'isola, chiamata nuovamente
col nome originario di Nisida, viene ceduta in fitto a vari personaggi,
finchè nel 1558 viene acquistata da Giovanni Piccolomini, duca di Amlfi
e sposo della Contessa Costanza d'Avalos. Nei trent'anni in cui egli fu
proprietario, Nisida fu abbellita con una vegetazione più curata, mentre
furono sistemate ad uso residenziale le costruzioni più importanti
dell'isola, tra cui la torre citata nell'inventario del 1485.
Nel 1588 Nisida passa nelle mani di Pietro Borgia, principe di Squillace,
anche se la Chiesa continua ad esigere un canone annuo. Tale
consuetudine continuò negli anni con i proprietari che succedettero.
Nel 1600 l'isola venne acquistata dai Principi Duchi
Macedonio. Nel
1623 era affittuario Giambattista Di Gennaro il quale, approfittando del
comodo e celato approdo di Porto Paone, fece dell'isola un centro di
raccolta e smercio per i bottini che i pirati delle acque circostanti
gli fornivano: il Di Gennaro fu poi scoperto e giustiziato.
Nel 1624 il vicerè di Napoli, Antonio Alvarez di Toledo, duca di Alba,
preoccupato per il dilagare della peste in tutto il regno, fece spostare
il Lazzaretto da Posillipo allo scoglio fra Coroglio e Nisida, che fu
perciò detto del Lazzaretto Vecchio. In seguito a ciò sorse una lite fra
il vicerè e l'allora proprietario di Nisida, Vincenzo Macedonio il quale,
accampando diritti di proprietà anche sullo scoglio del Lazzaretto
Vecchio, mostrò di non gradire la presenza ravvicinata del Lazzaretto.
Alla fine un accordo fu trovato e il Macedonio ricevette un cospicuo
indennizzo. Il Lazzaretto fu poi completato nel 1628.
Nel 1648, durante la rivoluzione napoletana, Nisida fu approdo di alcune
navi spagnole che, insieme ad una guarnigione di soldati, ebbero il
compito di tenere impegnato il Duca di Guisa, mentre il vicerè si
riappropriava della città, mettendo fine alla rivolta.
Successivamente Nisida, pur rimanendo di proprietà dei
Macedonio, venne amministrata dalla famiglia dei Pietroni,
parenti dei proprietari: nel 1769 fu
fatto un primo apprezzo per conto del sovrano borbonico che intendeva
acquistare l'isola per farne una riserva di caccia, ma la trattativa non
ebbe seguito.
Nel 1814 Nisida fu
destinata da Gioacchino Murat a luogo di caccia. Con la restaurazione dei Borboni,
avvenuta l'anno successivo, l'isola passò al Demanio: in tale occasione
fu stilato un apprezzo, importante testimonianza dello stato degli
edifici e del territorio isolano a quell'epoca. Il Palazzo, costruito
tempo prima dal Piccolomini, divenne sede di un ergastolo che ospitò tra
gli altri Carlo Poerio, Luigi Settembrini, il Pironti, il Farcitano e
altri liberali italiani. Esso venne ricordato per le condizioni disumane
in cui versavano i detenuti e che furono sdegnosamente descritte dallo
statista inglese Guglielmo Gladstone che lo visitò. Ben diversa fu
l'opinione della scrittrice inglese Jessie White Mario che nel 1877
visitò il carcere trovando i carcerati in buone condizioni di vita con
vitto ed alloggio di ottima fattura. In conclusione ella finì per
credere che la mancanza di libertà per i detenuti finiva col non pesare
su di essi, i quali perciò erano invogliati a commettere reati pur di
restare in carcere!
Nel 1832 iniziò la costruzione del porto di NIsida, dal lato che guarda
la terraferma, dove secoli prima i Romani avevano il loro approdo. Poco
tempo prima infatti l'architetto Giuliano De Fazio aveva ritrovato le
due serie di "pilae" che
costituivano i moli del porto romano: questo portò ad un vasto dibattito
fra coloro, come il De Fazio, che volevano costruire i moli su piloni,
seguendo l'antico uso, e coloro che, sostenendo che le "pilae"
ritrovate fossero le arcate di un acquedotto, propendevano per la
costruzione di moli compatti. Alla fine si decise di costruire il molo
di levante su 7 piloni, quello di ponente su 4, come voleva il De Fazio.
Ma nel 1834 il De Fazio morì lasciando l'opera incompiuta: il precoce
logoramento cui andò soggetta, creò lo spunto per nuove polemiche. Così
nel 1847 i lavori furono ripresi con la costruzione di un nuovo molo che
congiunse Nisida allo scoglio del Lazzaretto Vecchio.
Tra il 1854 ed il 1858 fu costruito un nuovo Lazzaretto sul lato
nord-est dell'isolotto, ampliando il porto per destinarlo ad uso dello
stesso Lazzaretto.
Agli inizi del nostro secolo, Nisida lega le sue sorti a quelle della
città, interessata da gravi problemi di sviluppo e di espansione. L'area
prospiciente l'isola, fu scelta per l'insediamento siderurgico dell'ILVA
di Bagnoli.
Nel 1926 l'Aeronautica Militare si insediò nella parte bassa dell'isola
e solo recentemente si è trasferita a Pozzuoli. Nel 1933 il
penitenziario venne soppresso e trasformato in riformatorio giudiziario,
mentre nel 1948 assunse la denominazione di Casa di rieducazione per
minorenni: esso oggi accoglie circa 200 minorenni, qui destinati perché
irregolari nella condotta e nel carattere.
 |
|
Lo scoglio del
Lazzaretto oggi inglobato nel ponte di accesso a Nisida |
Oggi quello che rimane degli antichi monumenti versa in condizioni di
estremo degrado. Salendo verso la cima dell'isola, dopo il primo
tornante, vi è una chiesetta dalla semplice facciata, costruita intorno
alla metà del XVIII° secolo. L'interno è ad unica navata con due accenni
di transetto: l'altare è finemente decorato con marmi policromi e
stucchi. Sulla destra della chiesa vi è il campanile semidistrutto,
mentre sotto la chiesa vi è un ipogeo in parte inaccessibile, un tempo
adibito alla sepoltura degli abitanti dell'isola.
Sulla cima dell'isola sorge la casa di rieducazione per minorenni,
costruita sul palazzo del Piccolomini. Essa è formata da un cortile
interno circolare, intorno al quale sorge un edificio a due piani (in
esso vi sono circa 70 celle, un pronto soccorso, la cucina e una cantina
sottostante). Al di sopra di questo edificio,
sorge una torre molto rimaneggiata: iniziata nel periodo angioino, fu
portata a termine successivamente non più per gli originari scopi
difensivi, ma soltanto per abitazione. Il tufo per la sua costruzione
proviene in parte da cave poste sull'isola stessa.
Presso il penitenziario sorge il cosiddetto
Cortile delle Scuole, costituito da un edificio al cui centro si apre un
cortile a base rettangolare con due ordini di finestre. Alcuni hanno
avanzato l'ipotesi che esso in origine fosse un chiostro dello scomparso
monastero di S.Arcangelo, in seguito inserito in un nuovo edificio.
Scendendo verso Porto Paone si scorge il Palazzo Borbonico, a due piani
per complessive 16 stanze. Presso di esso sorgeva il Cimitero dei
forzati con annessa cappella, oggi semidistrutta.
Da qui si giunge a Porto Paone, usato in epoca romana come ricovero per
le navi, ma non come porto a causa della sua limitata profondità. Il
porto vero e proprio dovette invece sorgere dove oggi si trova
l'insediamento della NATO, chiuso da due moli traforati, in una zona al
riparo dai venti.
Sulla striscia di terra che chiude Porto Paone dal lato destro, vi sono
i resti della Batteria Borbonica, postazione difensiva che ospitava un
certo numero di cannoni.
|